di Vito Bianco
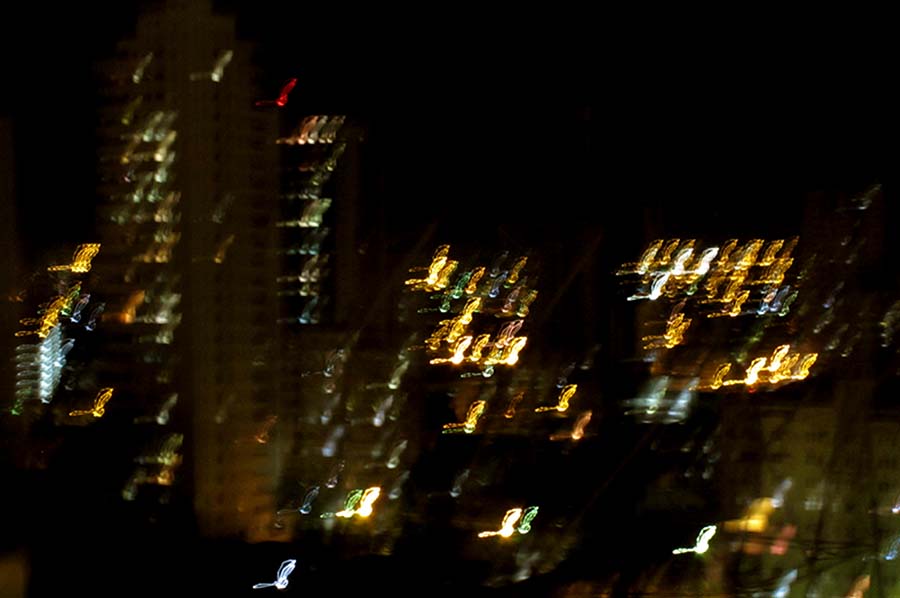
Arriverà tra poco; ancora quindici minuti e sentirò il suono discreto delle sue scarpe di pelle lucida sugli alti gradini che finiscono al quinto piano di questo settecentesco palazzo sulla Hohenstaufenstrasse. Sono venti, ha detto ieri sera, mentre con una lentezza che a volte trovo esasperante si portava alla bocca una cucchiaiata di minestra di farro e lenticchie. Va bene, ho pensato, il numero conta niente conta quello che c’è nelle pagine. Stavo per dirlo, ma il suo sorriso scoraggiato, distante mi ha fermato, mi ha fatto capire che sarebbe stato inutile, che non gli avrei fatto cambiare idea. Eppure continua a scrivere. Scrive di mattina, dopo aver bevuto una tazza di latte caldo con una goccia di caffè, e di notte quando, svegliandosi da un breve sonno che immagino inquieto, mi cerca con la mano per sentire che sono ancora accanto a lui.
Vedi, mi ha confessato due sere fa, per me la cosa più importante è continuare a riempire di segni i fogli. Sono parole che hanno un significato, ma potrebbero anche essere caratteri incomprensibili di un’ altra civiltà. Anzi, se lo fossero sarei più contento: pensa a quanto sarebbe bello scrivere un libro con parole che si possono pronunciare ma non vogliono dire nulla. Chi lo leggerebbe un libro così?, gli ho domandato. Ha alzato le spalle. Qualcuno lo leggerebbe, mi ha risposto, chiudendo per un momento gli occhi.
Questo libro che immagino, ha continuato, somiglierebbe a una partitura musicale priva di indicazioni espressive. Ciascun lettore potrebbe suonarlo come vuole, guidato dall’umore del momento. Che ne pensi? Ho fatto passare qualche secondo, riportato una ciocca di capelli dietro l’orecchio, e ho risposto che per me un libro, una storia deve avere un significato, magari non del tutto chiaro, ma deve averlo, con dei personaggi che almeno un po’ mi somiglino.
E i miei ti somigliano?, mi ha domandato; e ha riso. Quelle poche volte che ride sembra un altro uomo. Non so dirlo, fa venire in mente la fine di un temporale visto da una finestra aperta su una pianura di campagna. Vorrei farmi capire, ma so che le mie parole non hanno nemmeno lontanamente la forza, forse sarebbe meglio dire, la sostanza, delle sue. Non è la prima volta che me lo chiede. Ogni volta mi confonde, perché se devo essere sincera quelle ragazze strane e quei giovanotti sperduti mi sembrano venire più da un sogno che dalla vita reale.
Sto pensando alla cavallerizza del circo, con tutte quelle ipotesi su quello che accadrebbe se si verificasse un certo fatto, o quel campione di un’arte a dir poco bizzarra: il digiuno. Per non parlare del ponte, che sente, pensa e parla come una persona come me e voi.
Ancora non sento rumori di passi che salgono. Aspetto. Senza di lui è come se tutto andasse in polvere. È secco e malato ma tenace, sostenuto da una forza insospettabile. Ho vissuto al caldo, attaccato a una stufa. Per tirare avanti mi è bastato un po’ di cibo e la carta bianca sulla quale trascrivere le storie che mi regala l’insonnia, mi ha detto. Chi, come me, non riesce a prendere contatto con la vita, con una mano allontana un poco la disperazione, e con l’altra può registrare ciò che vede sotto le macerie, dato che possiamo considerarlo una specie di – ha fatto una pausa, si è toccato la punta del naso col mignolo della sinistra – di sopravvissuto.
Rianimo il fuoco del camino, mi lavo le mani nel lavello di smalto, vado alla finestra mentre passa un tram che riporta a casa gli impiegati del Ministero e della Banca Goldstein. Gli operai da queste parti si vedono soltanto la domenica, con i vestiti nuovi e i bambini schiamazzanti intorno.
Abbiamo conosciuto, allo Steglitz, una bambina che aveva perso la sua bambola; piangeva e la madre non sapeva cosa fare per consolarla. Le diceva: Te ne compro una nuova, più bella; ma lei scuoteva la testa e ripeteva che voleva la sua Brigida.
Lui ha preso da parte la donna e le ha detto che c’era un modo per calmarla: farle credere che Brigida era partita ma che le avrebbe scritto dai posti che avrebbe visitato. E così ogni giorno va al parco a leggere alla bambina una lettera della bambola in viaggio scritta da lui. Elsi lo ascolta a bocca aperta, sorride e tutti i giorni alla stessa ora l’aspetta sotto il pioppo più alto, alla destra del cancello d’ingresso. Prima di uscire me la legge. Se dico che va bene, prende il cappotto, la sciarpa e il cappello ed esce, contento. Ma se ho qualcosa da dire su un aggettivo o la descrizione di un quadro (Brigida naturalmente visita mostre e musei) si risiede e fa le modifiche che gli suggerisco. Lo guardo e mi accorgo che l’attenzione è la stessa di quando scrive uno dei suoi racconti per lettori adulti: immobile, concentrato, la mano sinistra a tenere fermo il foglio, la testa inclinata sulla lampada da tavolo, le gambe accavallate.
Fuori hanno acceso i lampioni. Non può tardare. Ho in mano uno dei quaderni. Al centro della prima pagina, un titolo: La tana. Sfoglio e leggo. Qualcuno, o qualcosa – una creatura – parla con una voce molto umana da un labirinto sotterraneo. Lo descrive mentre scava e avanza, per arrivare in superficie, credo.
Il mondo è per me l’estraneo, mi ha detto in sanatorio. Per resistere ho costruito una specie di tana d’inchiostro dal cui ingresso ho cancellato le tracce. Tutto il mondo no, ho ribattuto, per rincuorarlo, per avvicinarlo di qualche centimetro al mio confine. Be’, forse tu no, mi ha risposto, conciliante. Né il buon Max, che ha sempre fatto egregiamente quello che sentiva di dover fare per me. Una pioggia improvvisa ci costrinse a una corsa fuori programma dal viale al gazebo al centro del giardino.
Dora, sono io.
È entrato ma non l’ho sentito. Ciao. Preparo il tè e sentiamo il notiziario delle sei, dico. Senza pensarci mi porto il quaderno nell’angolo della cucina e lo nascondo dove non potrà trovarlo: dentro la cassetta dei medicinali appesa al muro.
Stasera voglio vedere le fiamme, dice. È dietro di me, mi mette una mano fredda sulla nuca.
Le vedrai. Sarà uno spettacolo unico: capolavori che vanno in fumo e si fondono con l’aria.
Capolavori, dici? Ma no, solo preghiere rivolte a un dio ignoto, o segnali luminosi nella notte.
Ci sediamo. Ci guardiamo. Mi porto la tazza alle labbra. Lui sorride, soffia sul bordo della sua. Aspetta.
