di Pepi Burgio
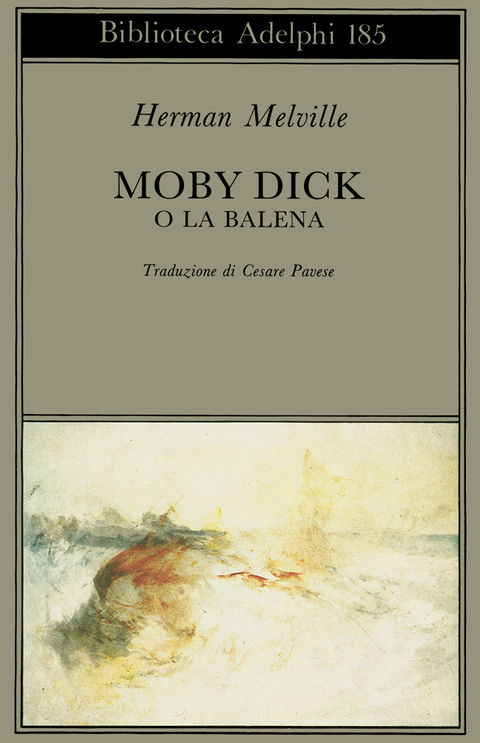
Quando nel 1932 Cesare Pavese pubblicava il saggio su Herman Melville, i nuovi studi nietzscheani erano ancora di là da venire. Soltanto alcuni decenni dopo, il contributo fondamentale di studiosi del valore di Giorgio Colli e Mazzino Montinari riuscirà a proporre un decisivo ripensamento critico delle opere del filosofo di Röcken alla cultura filosofica europea.
Diciamo questo perché l’insistenza di Pavese circa la “grecità” della poetica di Melville in Moby Dick, oggi, alla luce delle acquisizioni raggiunte grazie al determinante contributo degli specialisti italiani di Nietzsche, richiede qualche precisazione. Che per Pavese Moby Dick sia “il poema della vita barbara” ed il suo autore un “greco veramente”, è opinione condivisibile. Ma ritenere che la “schiettezza serena e virile” reperita nel romanzo sia caratteristica dell’ “equilibrio che usiamo chiamare greco”, appare una distorsione interpretativa, un cliché percettivo, affermatosi inizialmente come vulgata della sensibilità romantica e destinato successivamente ad autoalimentarsi. Per più di un secolo tale banalizzazione ha comportato che la complessa civiltà dei Greci venisse svilita e fatta coincidere con il modello classico di bellezza serena, effetto di proporzione, misura, armonia, etc.. La civiltà greca non è un unicum, l’ethos barbarico da un lato e il sereno equilibrio dall’altro, segnalano cifre spirituali e temperie storiche assai diverse tra loro. Maggiore interesse rivestono piuttosto gli altri spunti critici proposti dall’autore di Lavorare stanca. Con Moby Dick, Melville, dice Pavese, ha disposto uno spettro interpretativo di smisurata vastità; e quindi, così come è peculiare di ogni opera letteraria d’eccellenza, “non si finirebbe mai di analizzarlo per scoprirvi nuovi angoli di prospettiva, nuovi sensi e nuova importanza”. Ma ciò che compiutamente svela ed esalta la finezza e la modernità dell’opera, è il frequente rimando allo spirito dell’Antico Testamento; questo, grazie alla sua problematicità ermeneutica, conferisce “senso indefinito all’allegoria” suggerita dal romanzo.
L’autore di Moby Dick, ricorda Pavese, è un uomo tormentato dal mistero del male e dall’orrore che pervade l’intero universo. Mistero che assume, nella misura più potente, un’impronta di sacralità, messa in rilievo ad inizio ‘900 dal teologo tedesco Rudolf Otto; e scrutato da un Melville avvolto da un’atmosfera “solenne e severa”, tipica, pensa Pavese, di quella “terribilità puritana” la cui presenza costante informa l’opera. Del saggio dello scrittore piemontese va ricordato infine la rilevanza attribuita alla fattura moderna del romanzo di Melville e, secondo una profonda intuizione critica, la speculare natura del rapporto di Achab con Amleto: “Achab non è un uomo come tutti gli altri. Lui delira, lui digiuna, lui veglia, lui parla come Amleto e, ogni tanto, fa allocuzioni al cielo”.
Harold Bloom, più di sessant’anni dopo, nel saggio Shakespeare: l’invenzione dell’uomo, ha sviluppato un’esemplare riflessione sulle tragedie del grande bardo e sull’Amleto in particolare, assumendo il principe triste di Danimarca come prototipo dell’uomo moderno: ansioso, ossessionato dalla ricerca di una forma per allestire una qualsivoglia personalità, e insieme immagine dell’ “enigmatico malessere” della civiltà occidentale, protesa con coscienza “ambigua e dilaniata” verso un improbabile altrove che possa dare requie al dramma posto dalla sua question.
Di Amleto, ha scritto ancora Harold Bloom, “non esistono elementi concreti che ci aiutino a definirlo”; di Achab, ha scritto Cesare Pavese, non è possibile alcun ritratto psicologico, tanto mutevole e caotico è il suo io.
Indubbiamente i due personaggi s’assomigliano.
L’articolo è pubblicato su Suddovest 14/11/2022
